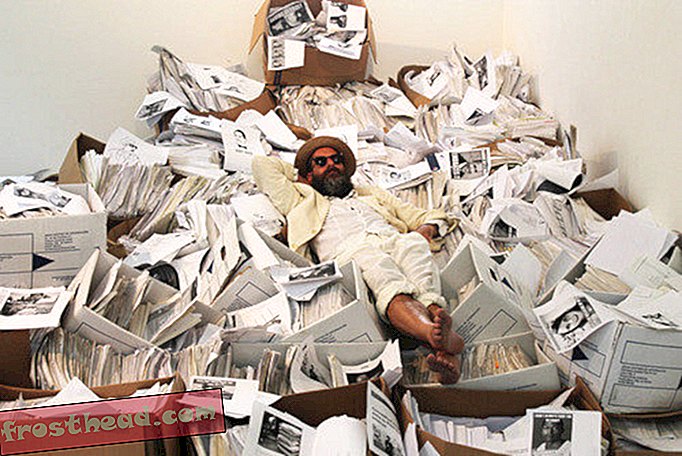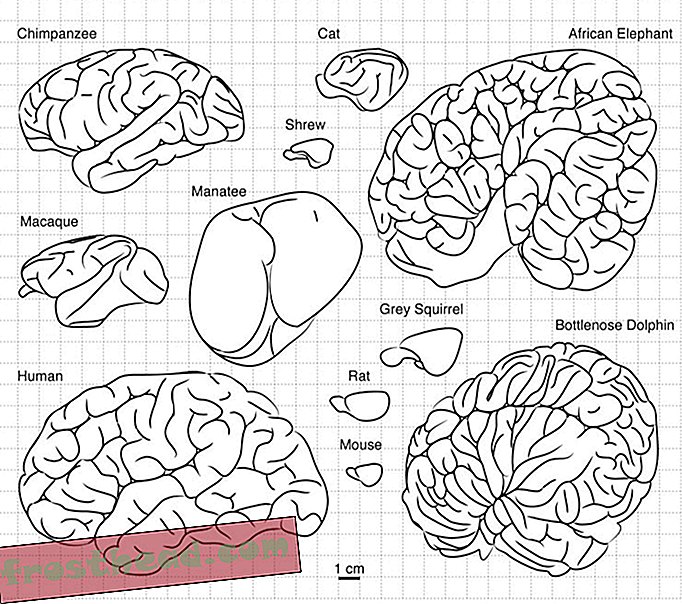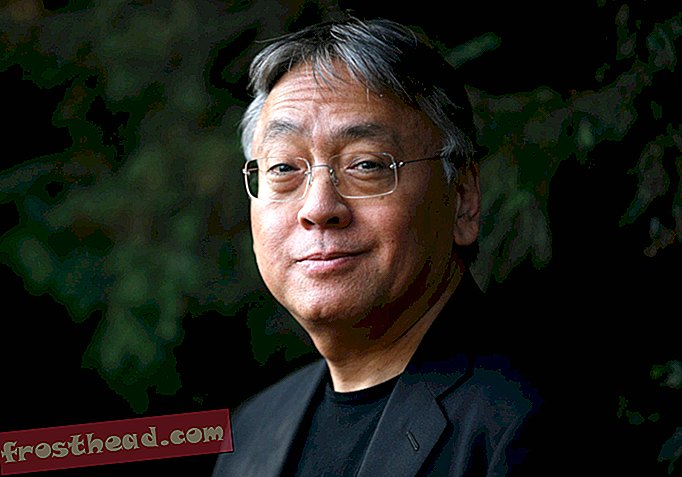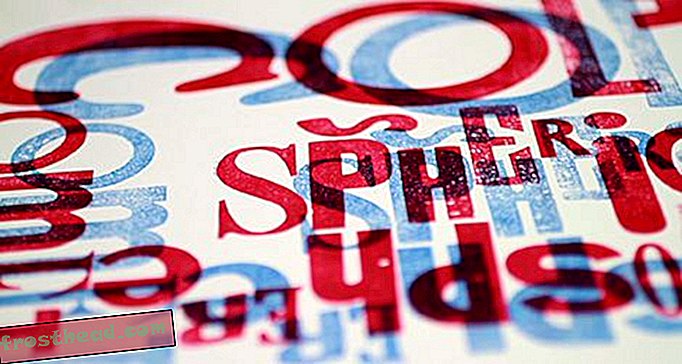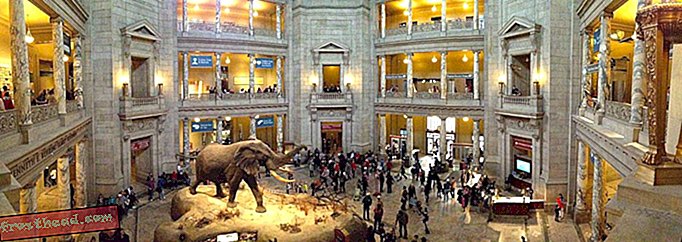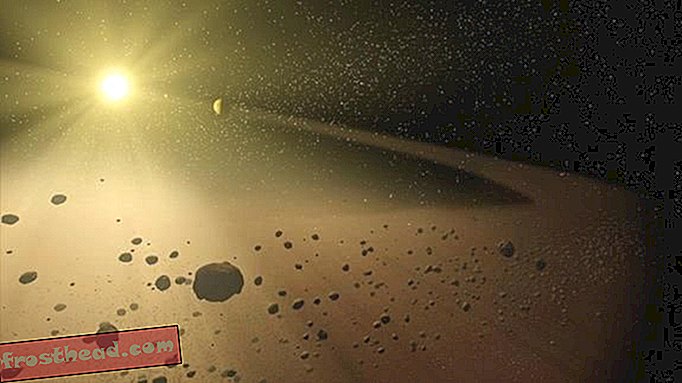Per quasi tre secoli, la casa dei Medici fu senza pari nella sua autorità sulla città italiana di Firenze. Con Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico e altri membri della famiglia che fungono da patroni, luminari artistici da Leonardo da Vinci a Donatello, Brunelleschi e Botticelli hanno guidato l'ascesa del Rinascimento italiano, cementando la centralità di Firenze nel nesso culturale dell'Europa.
Ora, una mostra comune ospitata da due dei più importanti musei d'arte della città - la Galleria degli Uffizi e il Museo del Bargello - ritorna alle radici dei sovrani rinascimentali mettendo in evidenza un aspetto meno noto delle collezioni della famiglia. Islam e Firenze: arte e collezionismo dai Medici al XX secolo, in mostra fino al 23 settembre, cataloga le relazioni dialogiche in corso tra Firenze e il mondo islamico attraverso una sontuosa esposizione di tappeti, oggetti in metallo, manoscritti e altri manufatti assortiti.
Hannah McGivern di The Art Newspaper riferisce che lo spettacolo è diviso in due parti. Il primo, ospitato agli Uffizi, si concentra sul periodo tra il XV e il XVII secolo, attingendo a quasi 150 oggetti islamici scambiati da mercanti fiorentini. I punti salienti includono ceramiche lustre della Spagna moresca e regali diplomatici, come una versione imbottita della giraffa dei Medici nella vita reale inviata da Sultan Qaitbay di Mamluk in Egitto a Lorenzo il Magnifico nel 1487.
Secondo un comunicato stampa, lo spettacolo degli Uffizi mira a esplorare le interazioni tra Oriente e Occidente, come testimoniano sia le opere d'arte scambiate che quelle prodotte da fiorentine ma influenzate dall'islam. Ad esempio, uno dei possedimenti ornati della galleria, la pala d'altare “Adorazione dei Magi” del 1423 tempestata di oro di Gentile da Fabriano, presenta caratteri arabi sugli aloni della Vergine Maria e di San Giuseppe. Un altro collegamento degno di nota: una serie di ceramiche della Spagna orientale e moresca adornate con gli stemmi delle famiglie più importanti di Firenze.
La seconda metà della mostra, in mostra al Bargello, si concentra sulla ricerca, il collezionismo e la museografia della fine del XIX e all'inizio del XX secolo. "In quegli anni Firenze era infatti frequentata da importanti collezionisti, italiani e stranieri, direttori di musei, curatori, tutti gli intenditori e gli ammiratori dell'arte islamica", afferma un comunicato stampa del Bargello.
Infatti, mentre il Bargello è noto per la sua collezione di sculture italiane, che comprende il capolavoro del 1430 di Donatello "David", il curatore della mostra Giovanni Curatola dice a McGivern che è anche sede della più significativa collezione di arte islamica del paese.
Le donazioni degli intenditori d'arte islamica del XIX e XX secolo Louis Carrand, lo specialista tessile Giulio Franchetti, l'antiquario Stefano Bardini e il collezionista Federico Stibbert integrano le proprietà delle collezioni medicee, producendo una mostra piena di tessuti intricati, placche d'avorio intagliate e una pletora di opere creato utilizzando metalli preziosi.
Esposizioni correlate in altre istituzioni di Fllorence completano la collaborazione tra Uffizi e Bargello: la Biblioteca Nazionale Centrale, sede di una serie di documenti che trattano temi islamici, custodisce il primo manoscritto noto del Libro dei Re, un poema epico persiano. Il Museo Stibbert, che prende il nome dal suddetto collezionista, presenta una Sala islamica affollata di armature e armi elaborate e connota il desiderio di Stibbert di registrare i "costumi, usi e tradizioni di popoli lontani". Il Museo Bardini, così chiamato come il collezionista che ha donato molti delle sue proprietà, offre un'esposizione di tappeti turchi, persiani e mamelucchi risalenti al XVI e al XVII secolo. A completare l'assemblaggio, la Villa Medicea di Cerreto Guidi, una villa del XVI secolo costruita per Cosimo I de 'Medici, ospita manufatti metallici, armi e maioliche (ceramiche dipinte) acquisite anche da Bardini.
Islam e Firenze: l'arte e il collezionismo dai Medici al XX secolo è esposto alla Galleria degli Uffizi e al Museo del Bargello fino al 23 settembre.